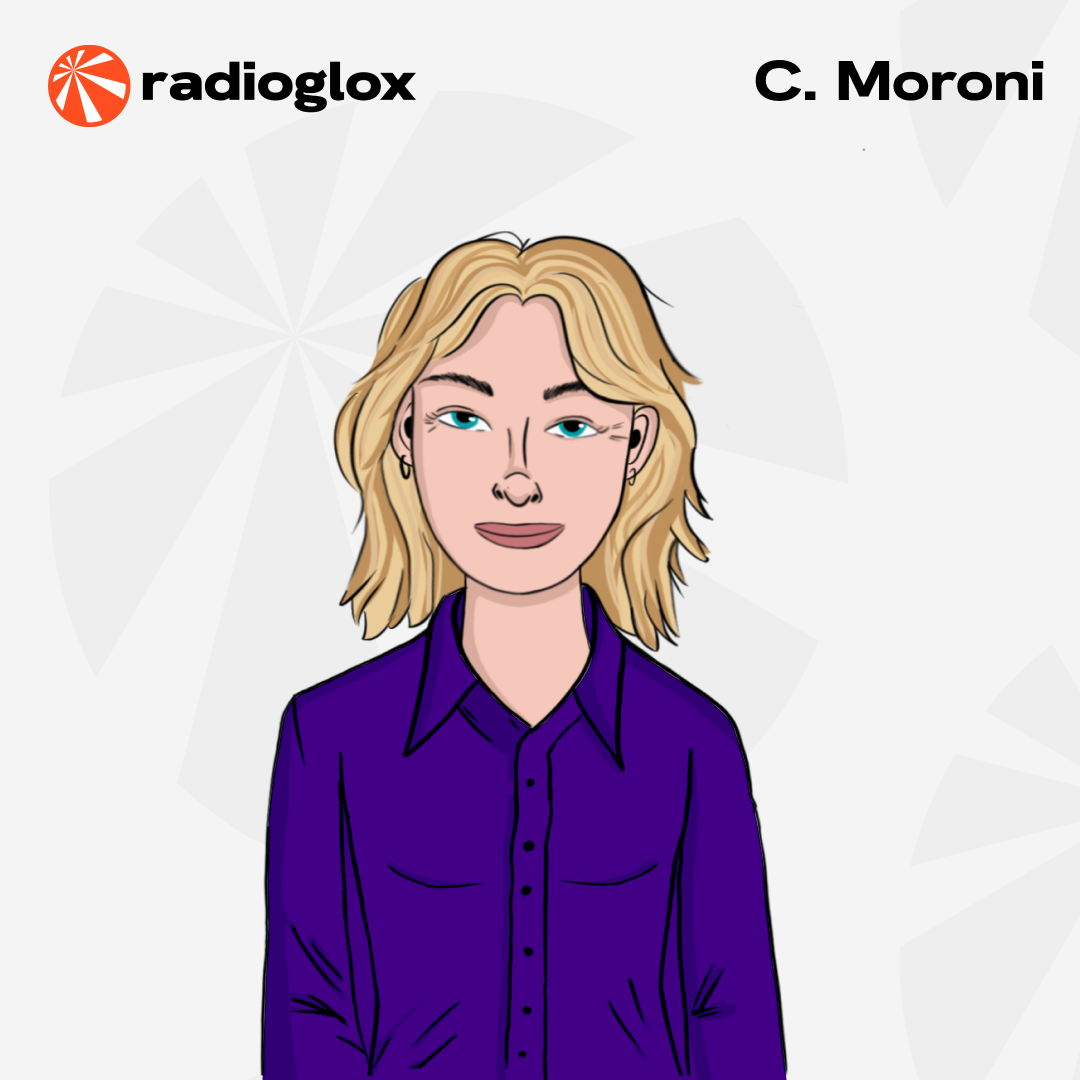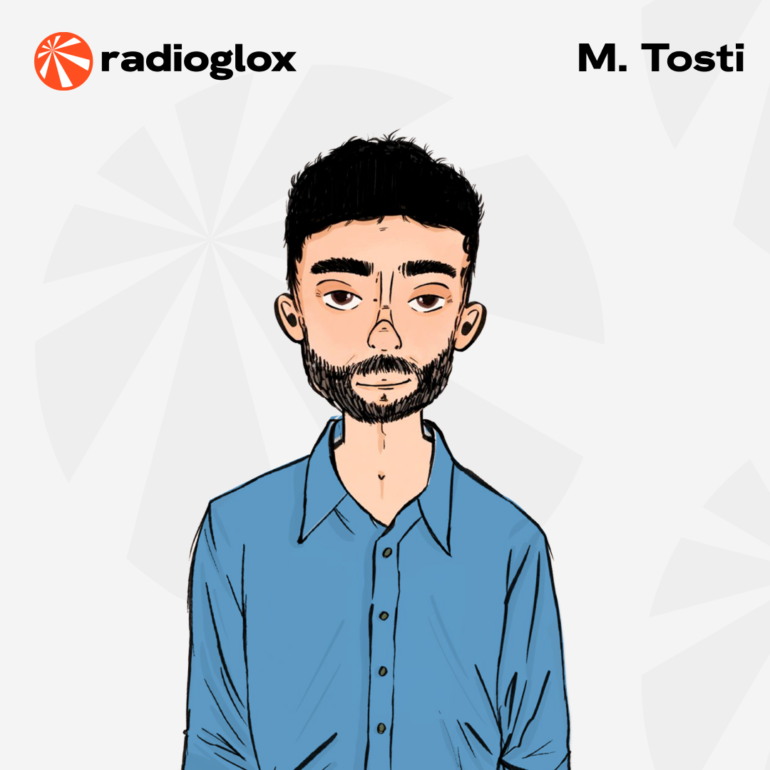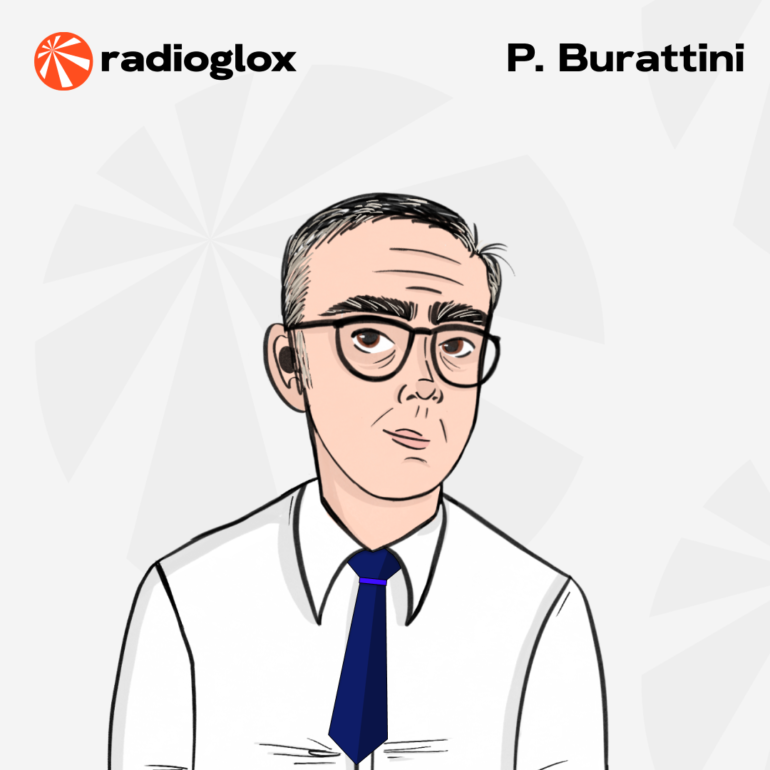Quando a gennaio del 2025 è uscito il volume Ipnocrazia di uno sconosciuto filosofo cinese Jianwei Xun – edito da Tlon e tradotto da Andrea Colamedici divulgatore e co-fondatore della casa editrice – è diventato velocemente un piccolo caso editoriale. In Italia, ma soprattutto in Francia.
Anche se, come si dice, un libro non si giudica né dalla copertina né dal titolo – che sono per lo più il frutto di una strategia di marketing – il termine Ipnocrazia che campeggia sulla copertina ha incuriosito anche me che da tempo lavoro sul concetto di percezione della realtà e sulla tendenza del “potere” a modulare queste percezioni. Utilizzando come fondamento sociologico, tra gli altri, un classico come La realtà come costruzione sociale di Peter L. Berger e Thomas Luckmann – secondo cui ciò che definiamo “realtà” non è mai un semplice dato oggettivo, ma il risultato di un costante processo di costruzione condiviso tra individui, gruppi e istituzioni – la mia idea è che oggi non è più necessario modificare la realtà stessa nel tentativo di dominarla, ma sia sufficiente definirne e guidarne la percezione che le persone ne hanno. Non conta più che qualcosa sia vero, ma che sia credibile, la realtà si costruisce attraverso il riconoscimento condiviso. Non è più necessario censurare per dominare, ma si deve moltiplicare: narrazioni, immagini, interpretazioni, finché il vero si perde nel rumore. Questo avviene anche grazie al fatto che il mondo fisico, da cui dovrebbe scaturire la verità esperita, è sempre più dissimulato dalla sua rappresentazione virtuale.
Nell’introduzione di Ipnocrazia l’autore parla di uno stato collettivo, di un regime che sostituisce la realtà con una ipnosi continua. Non siamo nel tempo della disinformazione e della post-verità, ma in quello della suggestione e della trans collettiva. L’ipnocrazia è in pieno svolgimento e al centro di questo regime del controllo totale della percezione della realtà ci sono Donald Trump e Elon Musk, ministri del regime ipnocatrico.
La lettura di questo saggio convince in alcuni passaggi, ma sembra eccessivamente apocalittico in altri. In generale pur offrendo suggestioni utili ad una riflessione, lascia una certa sensazione di incompiutezza. Comunque mi è sembrato un punto di partenza interessante. Di contro ho provato un certo fastidio per l’uso di conseguenti frasi brevissime, simili ad un processo ipnotico appunto, di definizione reiterata di concetti lapidari.
Qualche settimana fa la giornalista dell’Espresso Sabina Minardi affascinata dall’idea presentata nel libro, ma insospettita da una serie di sue caratteristiche intrinseche incongruenti, ha svelato la verità autoriale su questo saggio: il filosofo cinese dichiarato autore non esiste affatto, il libro è stato scritto da un “collettivo” composto di intelligenze umane e intelligenze artificiali coordinate dal Colamedici, il dichiarato traduttore-editore del saggio.
In sostanza si tratta di un libro scritto con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, e diffuso come un eccezionale caso di intuizione filosofica sulla realtà contemporanea. L’obiettivo, a dire di Colamedici, non era l’inganno, ma realizzare una performance narrativa che costruisse la stessa realtà che il libro analizzava teoricamente. E dimostrare così che l’ingegno umano può trovare aiuto e sviluppo grazie all’ausilio dell’intelligenza artificiale.
L’operazione ha causato diverse reazioni negative soprattutto in chi si è sentito ingannato ed ha magari confrontato la propria fatica intellettuale nel produrre pensiero e scritti con l’apparente semplicità di chiedere ad una macchina di fare il lavoro più gravoso.
Io ho provato un certo divertimento per la cosa nel suo complesso, ma soprattutto molta curiosità per le implicazioni che questa operazione porta con sé e ritengo che sia su questo che dovremmo concentrare le nostre riflessione, passato il momento dell’indignazione e delle proteste.
Oltre ad alcuni spunti per una teoria della manipolazione della percezione, Ipnocrazia suggerisce che l’AI se guidata con intelligenza, umana, produce amplificandola una “descrizione” del pensiero che così resta unico, la standardizzazione si realizza solo se ci si limita a seguire acriticamente i generici suggerimenti della macchina. In fondo la creatività umana è da sempre il frutto di una elaborazione interconnessa di soggetti, strumenti, ambienti e contesti: la AI potrebbe diventare uno degli elementi che contribuiscono all’atto creativo originale.
Non possiamo sapere se Colamedici avrebbe svelato la natura vera dell’operazione se non fosse emersa pubblicamente, forse avrebbe lasciato ancora per un po’ che la sua “creatura” fosse al centro di entusiastici commenti e che le casse della casa editrice continuassero a godere del successo editoriale. Nel moneto in cui l’esperimento è stato scoperto per quello che è, io l’ho trovo molto interessante: spostare il dibattito sulle potenzialità della AI dalla teoria alla pratica è probabilmente un modo concreto per sperimentarne e forse limitarne consapevolmente e funzionalmente l’uso.
In definitiva la domanda generale che mi sembra essere anche il fulcro dell’operazione, una volta svelata, di Colamedici è: “quanto siamo inclini ad accettare e a credere ad una teoria co-creata tra uomo e intelligenza artificiale? Fino a che punto siamo disposti a delegare l’articolazione del pensiero ad un sistema di artificio digitale?”
Chiara Moroni